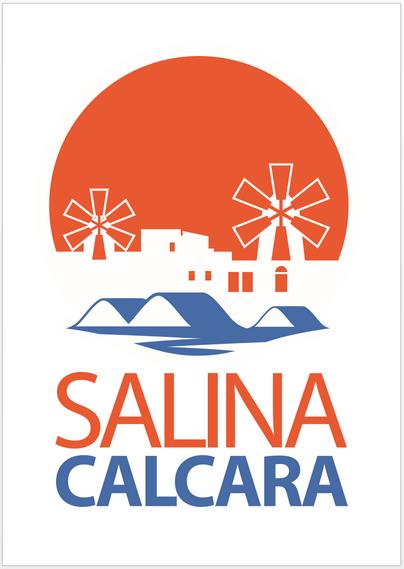Storia della Salina Calcara: origini e proprietà delle Case Calcara
Le Case Calcara erano già realizzate nel 1586, rispetto all’impianto della salina che risale al 1504, quando Alessio de Alfonso, – nipote di Antonio costruttore della salina e figlio di Francesco -, fece edificare la chiesa o cappella di S. Alessio, per celebrarvi la S. Messa nei giorni di Domenica e solennizzare il giorno memoriale del Santo, il 17 Luglio….